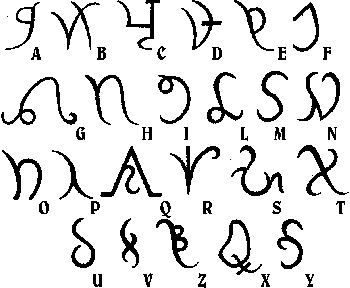Con le mie brutte e paurose oscurità trapiantate su un paio di gote troppo paffute per crederci. Così ho sempre amato visceralmente la luce, quasi a volermi illudere che potesse guarirmi da quelle oscurità che mi hanno accompagnato, sgraditissime compagne di viaggio, per larga parte della mia vita; però sono nato in una casa non grande, e con troppa gente. In più c'era anche la nonna, che viveva con noi; e la fissazione di mia madre, comune del resto a tante donne della sua generazione, di volerci avere il salotto. Il salotto è sempre la parte più orrenda di una casa, ricettacolo di mobilacci “in stile”, di cianfrusaglie, di “piccole cose di pessimo gusto”; in più mia madre, a un certo punto, insistette pure per metterci la carta da parati. E guai a entrarci, a parte nelle ore serali per guardare la televisione che troneggiava su una specie di trespolo.
Il risultato del salotto è che io, mio fratello e mia nonna si doveva dormire nella stessa stanza; uno dei motivi per cui, a un certo punto, fummo costretti a emigrare in cantina. Proprio così: in una piccola cantina condominiale, ovviamente solo durante il giorno perché non c'era lo spazio per tenerci nemmeno una brandina pieghevole. Finché mio fratello rimase in casa, io ci potevo andare soltanto quando non c'era; oltre alla scrivania e ai suoi libri, era riuscito non si sa come a metterci un piccolo laboratorio fotografico con delle strane lampadine colorate che mi affascinavano. C'era un minuscolo finestrino che, peraltro, dava su un sottoterrazzo nel cortile che faceva passare luce sì e no per dieci minuti al giorno (ma, quando passava e la giornata era particolarmente soleggiata, creava degli effetti stranissimi e meravigliosi, mescolandosi col pulviscolo).
Passarono gli anni, quelli dell'infanzia; un giorno, nell'autunno del 1974, quand'ero già in prima media, mi fu comunicato che mio fratello (già diplomato) rinunciava alla cantina e che me la consegnava, con tanto di chiavi. Se ne sarebbe andato di casa di lì a non molto, era già fidanzato e si è sposato giovanissimo. Comincia qui questa storia, la storia di una stanza tutta per me, così tanto per parafrasare Virginia Woolf. Ed è una storia che tuttora non mi risulta facile da raccontare: a poco più di undici anni, poiché per andare in cantina non era necessario passare da casa (si poteva entrare dalle scale e dal garage), mi ritrovavo di botto dalla promiscuità forzata della casa ad una stanza indipendente, seppure uno sgabuzzino. Non sapevo capacitarmene. Specialmente perché mio padre mi consegnò anche le chiavi del portone dello stabile: voleva dire, più o meno, andare e venire quando mi pareva.
Se avessi seguito le inclinazioni che avevo a quell'età, avrei fatto l'elettricista. Fin da piccolissimo sbavavo per spine, prese, fili elettrici, interruttori e lampadine. A otto anni, su un grosso pannello di masonite, avevo costruito una specie di circuito che, oh, funzionava; le lampadine si accendevano, perlomeno. Avevo uno scatolone enorme pieno di materiale elettrico, e mi ci divertivo come un matto; e alla classica domanda “cosa vuoi fare da grande” non avevo mai dubbi. Macché astronauta, macché ingegnere, macché missionario: io volevo fare l'elettricista.
Ma un conto è un pannello di masonite, un conto è una stanza propria. Naturalmente presi il mio scatolone e mi misi subito all'opera: piattine inchiodate al muro, portalampade, prese ficcate nei posti più impensabili. Al primo tentativo feci saltare la luce in tutto lo stabile; le prove successive andarono molto meglio. Alla fine contemplavo fiero l'opera mia; ero riuscito persino a mettere una lampadina all'esterno della porta, in modo da non accendere la luce del corridoio condominiale.
Come arredamento, un vecchio armadio vetrato nel quale avevo sistemato i miei libri; al termine della sua storia, la cantina sarebbe diventata un ammasso di mensole dove ce ne stavano quasi un migliaio. E' stato in quegli anni che ho sviluppato la mia particolare tecnica per la sistemazione dei libri, che è assolutamente maniacale. Tutti allineati alla perfezione con tanto di riga, e posti in modo da fungere da base ad altri sistemati in orizzontale. La adopero tuttora.
Alle pareti cominciai a appiccicare di tutto. Una stranissima foto di mio fratello, una “composizione” con una lampada accesa, uno sgabello e la prima pagina di un vecchio giornale che riportava la notizia della morte di Feltrinelli saltato assieme alla sua bomba sul traliccio. Il manifesto del meeting di atletica leggera Italia-Cuba, stadio Comunale di Firenze, 1° giugno 1972. Un Che Guevara ritagliato sempre da un giornale. Disegni fatti da me, che non ho mai saputo disegnare nemmeno la casina col comignolo. Calendari. E cominciai a passarci le giornate, a volte con alcuni amici che magari, a casa loro, avevano una bella stanza, ma che non era “la cantina del Venturi”. Cominciò, senza che lo volessi, a diventare una specie di mito; e cominciò anche la mia trasformazione, il mio passaggio. Esaurita la passione per le spine e le prese (ma ogni tanto ci davo un'aggiustatina, comunque), cominciai a scoprire l'essere da solo con se stesso. I pensieri. E la voglia di metterli su un foglio di carta.
A volte, scherzando, dico di avere imparato a scrivere a macchina prima che a mano. Non è vero; ma a sette anni e mezzo già battevo tranquillo sulla Lettera 32 di famiglia. L'ho letteralmente consumata, prima di sostituirla con una monumentale “Olympia” tedesca, presa da un rigattiere, che non ha mai ceduto. Poi ho avuto due macchine elettriche, anche belline, ma non erano la stessa cosa. Cominciai a scrivere raccontini: il primo parlava delle improbabili avventure di un cane, poi qualcosa che aveva a che fare con l'alluvione di Firenze e infine, ahimé, verso i tredici anni venne il momento delle immancabili poesie. Qui devo fare uno sforzo per riportarmi letteralmente a quell'età, una specie di stecco magrissimo alto quasi un metro e ottanta, brutto, sgraziato, spesso puzzolente come si puzza tutti quanti nell'adolescenza incipiente, dedito allo sfinimento da seghe, con la voce che cambia e con i pensieri “seri” che si affacciano. Tipo: la morte. De André c'era già, diviso tra un mangianastri a cassette regalatomi dalla nonna e il vecchio “Gelosino” che funzionava ancora. De André cantava che la morte sarebbe venuta all'improvviso e che avrebbe avuto le tue labbra e i tuoi occhi. Che accidenti sarà stata, 'sta morte?
Eppure l'avevo già vista, in diretta, da bambino. Il 4 luglio del 1968, quando ancora non avevo cinque anni e, a tavola, all'isola d'Elba, la mia bisnonna, Dini Giuseppa, che sapeva andare a dorso di mulo, mentre mangiava il pesce era sbiancata in volto e era passata dall'altra parte. E' un'immagine che non mi abbandonerà mai, una di quelle che magari rivedrò nel “film accelerato della vita” quando toccherà a me. Ma, a quell'età, i pensieri non c'erano. C'erano solo le immagini. A tredici anni era un po' diverso. Cominciava la coscienza precisa, e non esiste età che più dell'adolescenza sia appassionata alla morte. La prima poesia che scrissi su un foglio di carta si chiamava “Ballata della morte in faccia”; mi ricordo (oso dire fortunatamente) solo del titolo. Era lunghissima, la strampalata storia della Morte che mi appariva lì in cantina, da sotto la scrivania, e dell'impari lotta che sostenevo con lei. Credo contenesse anche una specie di “testamento”, e anche lì De André si faceva vedere. E scrivi, scrivi, scrivi. Diventare grullo dallo scrivere, mentre mi accingevo, senza saperlo, a diventare quasi matto sul serio. Non mancava molto; a quindici anni o poco più cominciò la mia “moltiplicazione”, e sospetto che quella cantina e quei pensieri troppo liberi e soli vi abbiano avuto una parte non indifferente.
Indipendenza! Che strana parola. Strana o non strana che fosse, a un certo punto mi venne in mente una cosa più strana ancora. Visto che mi ero già inventato una lingua personale, e che ad una lingua deve corrispondere un territorio, perché non creare uno stato indipendente? Credo di averci rimuginato per dei mesi; alla fine compii il gran passo. Indipendenza! Su un foglio di un album da disegno feci la bandiera con le matite Giotto: a bande verticali, rossa, gialla e verde, e con un cuore rosso nella banda centrale (quella gialla). Scrissi la costituzione, in italiano, in inglese e nella mia lingua (il kelartico), consistente in due soli articoli:
Qui si può fare tutto quello che si vuole.
I cittadini della FBCR non hanno nessun obbligo.
Già, FBCR. La sigla che cominciai a mettere su tutti i miei libri, accompagnata dal cuore rosso; su tanti ce l'ho ancora. Quello “stato” in una cantina condominiale, nato dalla fantasia e da una buona dose di solitudine di un ragazzino, si chiamò: The Free Bird's Cellar Republic.
Verso il diciotto un mezzo passo del quarto.