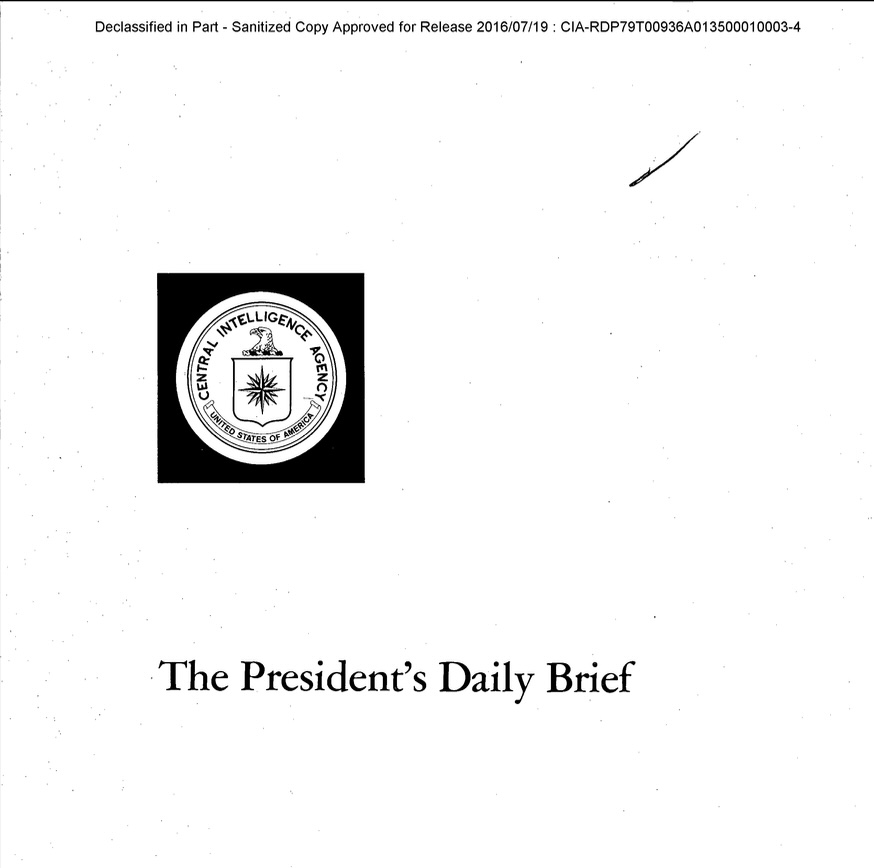domenica 28 febbraio 2010
Forza Livorno!

sabato 27 febbraio 2010
giovedì 25 febbraio 2010
Arturo ed io

Arturo l'ho conosciuto verso il '78, in estate, dal giornalaio in piazza della Fontana a Marina di Campo (che allora si chiamava ancora "piazza Milano"). Santi Guerrieri, c'era scritto con le lettere in rilievo sul muro; meravigliosa combinazione di cognomi. Giornali, libri, parole crociate, creme solari, salvagente e paperette di gomma, preservativi: l'estate. Ci si mise a parlare subito, con Arturo, sebbene non conoscessi ancora particolarmente bene la sua lingua (che, oltretutto, usava in una maniera del tutto bizzarra). Si vendeva. Stava lì, fermo, con qualche fotografia, e si dava. Aveva qualche mese, forse un anno più di me; s'era ragazzi. E che ragazzi, porca madonna.
Andò a finire che si fece subito non dico amicizia, perché "amicizia" è una parola abbastanza del cazzo, detto fra noi. Si fece non so cosa. Me lo portavo dietro, lui che non era molto pratico dell'Elba e in più soffriva abbastanza il caldo provenendo da latitudini fungose; gli facevo vedere un po' di tutto, parlandogli sbagliando la grammatica, e lui in compenso mi parlava d'una cosa misteriosa che si chiamava "assenzio" e ogni tanto mi toccava voluttuosamente il culo. Gli piaceva camminare e s'andava per certe stradette in salita, finché un giorno non mi venne l'idea di fargli vedere Galenzana. A dire il vero non so se gli piacque. Guardava e compitava con le dita dei versi che non capivo. Con gli sguardi ci sfogliavamo, diciamo così. Se passava un uomo con un'arma a tracolla mostrava interesse e competenza, ché ancora se ne vedevano di vecchi con il fucile.
Un giorno scomparve, di brutto. Non so proprio dove se ne fosse andato. Lo aspettavo, come ogni mattina, al muretto davanti al "Capriccio"; non si fece vedere. L'Ornella, la torinese con gli occhi azzurri, mi chiese dov'era finito; non le seppi dire niente e non mi riuscì mai di baciarla. Sfogliavo, e mi accorgevo che però continuava a dirmi qualcosa; era andato per le sue strade.
Molti e molti anni dopo, quando la consuetudine s'era fatta allegra disperazione, la sorte mi portò lontano; e talmente lontano da non riconoscere più il cielo. Erano le undici di sera e era ancora chiaro, alla fine di giugno; però bisognava mettersi qualcosa di pesante addosso, faceva freddo e le stelle indicavano qualcosa che non mi era consueto. Un giorno qualsiasi, dopo una mangiata colossale di salade au lard, con una scusa qualsiasi mi feci dare la macchina blu targata 08. E fu là che lo incontrai di nuovo.
Nella piazza della stazione, davanti al gazebo dove sonava un'orchestrina tutta compìta, elegante, davanti all'uditorio domenicale coi cappelli di paglia anche se non era domenica. "Toh, ma guarda chi si rivede", gli dissi; e mi fece cenno, con un sorriso di cortese complicità, di stare zitto. Aveva un quadernetto in mano pieno di seduti e di dormienti nelle valle, e con lui c'era un tipo grassoccio, palesemente rovinato dal bere, che gli lanciava occhiate che neppure l'amore immagina, e le occhiate sparavano camelie sanguinose. Capii di non dover essere troppo invadente; non eravamo più ragazzi, forse, eppure lo eravamo ancor di più di prima. L'orchestrina attaccò un motivetto idiota, alla moda; la stazione si disfaceva e il tempo assieme a lei. Nel cimitero circondato da palazzi moderni di quella piccola città gonzaghiana, una tomba di famiglia borghesava ritmi paludati mentre comitive di danesi scattavano fotografie berciando det er ham, den berømde digter. Il gazebo decollava e allora decisi di andarmene, ché ero fuori posto. Del resto ho passato tutta una vita a essere fuori posto, e una volta di più non faceva differenza; mi diressi verso il fiume.
Chiatte ormeggiate, birra dovunque, e il ponte. Sul ponte, una specie di tozza costruzione nella giornata di luglio che s'era fatta piovosa e quasi gelida. Non c'erano più né Santi né Guerrieri. C'era la comprensione del destino e dell'inadeguatezza; gli altri possono, e Arturo mi ha sfiorato, e quei venticinque giorni da diciassettenni all'Elba si dilatavano come chimere paracadutate a casaccio. Entrai nella costruzione, goffo, curvo, e al bancone una signorina graziosa sorrideva piuttosto mentecatta. Un biglietto, un soldo. Lo presi e mi scivolò di mano. Non so quale aura lo fece andare proprio sotto il bancone, in un posto pressoché irraggiungibile; la signorina mi guardava con aria fintamente desolata, pregustando un nuovo soldo.
Il fatto era che, sopra il bancone, Arturo mi guardava. Da un manifesto enorme, che lo ritraeva come quando lo avevo conosciuto all'Elba, seppure fosse vestito di tutto punto e persino con la cravattina lavallière. Un ghigno come a dire: "O dai, su, fagliela un po' vedere"; e allora le dissi che non c'erano problemi. Il bancone sarà pesato un centinaio di chili buoni. Lo presi con due mani, e lo sollevai di quel tanto che bastava per ritrovare il biglietto. La signorina era un po' sconcertata, un po' spaventata: Voilà le billet! E dentro c'erano foto, manoscritti, manonienti, manosilenzi, manovite e mano nella mano; ché era saltato fuori dal manifesto, con le sue armi da vendere e mi recitava, con aria divertita e lurida al tempo stesso, di certe sue stagioni, e di certi suoi inferni, e di certe sue volte in cui era morto per poi darsi, vivo, a chi era disposto a ricordarsi acque che cantavano di cristallo attraverso un sole che scivolava piano, piano, piano nel movimento d'un cuore sporcato da un fuoco maligno d'amore.
mercoledì 24 febbraio 2010
Il sassolino rosso

In questo momento, e sono andato persino un momento a controllare, siamo in una fase mediana. La ghiaia compattata resiste nelle zone laterali, quelle meno battute; al centro, dove passano e ripassano gli automezzi, è già un pantano. Presto dovrà arrivare di nuovo il camion, e si aggiungerà un altro strato; quello precedente verrà inghiottito, ed il primo scivolerà ancora più in basso.
In un angolo sperduto, dietro la tettoia, resiste un sassolino. Uno solo. Nessuno sa dove sia di preciso, tranne me: è perché ce l'ho messo io, in quel posto dove nessuno lo potrebbe mai trovare. È colorato di rosso, col pennarello. Quando il colore sbiadisce, lo vado a ripassare e poi lo rimetto dov'era. È un sassolino del primo strato. Mi venne quella strana idea nel maggio del 1987, meno di un mese dopo che l'associazione si era trasferita nella sede dov'è ancora oggi. Non appena fu data quella prima passata di ghiaia, una mattina che ero solo presi un sassolino qualsiasi, gli feci il trattamento di cui ho parlato prima e lo andai a mettere in quel posto dove nessuno va mai. Da allora è sempre lì.
Lo vado a "trovare" spesso, il sassolino rosso. Come se avessi qualcosa da dirgli, da raccontargli. Come se anche lui ne avesse. Premurandomi di non essere mai visto da nessuno, lo prendo in mano e me lo rigiro un po'; poi lo rimetto dov'era. A volte lo copro con un po' d'erba, certo comunque di ritrovarlo; la consuetudine è oramai tale che lo troverei anche a occhi chiusi, o nel buio più fitto.
A questo punto, magari, chi legge si attenderà un qualche paragone; com'è, altrimenti, che uno si metterebbe a raccontare questa storia vagamente assurda? Un paragone con qualcosa della vita, con i ricordi affidati a un sassolino colorato, e forse addirittura con quel che il sassolino avrebbe "visto" in tutti questi anni. Ho sempre trovato ridicolmente deliziosa la storia degli oggetti che "vedono"; l'ulivo millenario, la casa diroccata, qualsiasi cosa. Il bello è che, spesso, ci si convince della cosa, ci piace convincersene. Quel sassolino, che magari avrà pure centinaia o migliaia di anni, ha quindi "visto" ventitré anni del luogo dove mi trovo; e sono io che, a volte, vedo attraverso di esso.
Scorre tutto nella testa. Facce, avvenimenti, voci. Qualcuno non c'è più. Come sentire dei passi, degli aliti. Come sentire qualcosa che batte. Qualche volta, se in terra non è bagnato, dopo aver riposato il sassolino rosso mi metto a sedere per due minuti cercando di fare attenzione ai gesti che faccio. Se mi prendo la testa fra le mani, o se fisso un punto qualsiasi. Non è nulla di cosmico. Non sento sopra di me nessun cielo, nessun universo. Nessun pensiero elevato mi passa per la testa. Sono soltanto solo col mio sassolino, e con i miei strati di non so che cosa. Ogni giorno qualcosa spinge il primo sempre più in fondo. Ogni giorno un camion che arriva. Ogni giorno palate.
Mi chiedo a volte se un sassolino del mio primo strato sia stato salvato, colorato in rosso e messo in una parte di me dove nessuno lo possa trovare. Vorrei, spesso in quei due minuti in cui sto a sedere dietro la tettoia, che fosse quel presunto sassolino a rappresentarmi, a dire chi ero, a far vedere com'ero prima che si accumulassero strati su strati. Ma non c'è. Non ho nessun sassolino. Aspetto quindi nuovi camion. Nel frattempo la notte avanza, e i rumori delle macchine si fanno sempre più radi. Un altro giorno e un altro strato se ne sono andati. In questo preciso momento ti stanno amando e odiando, tutti coi loro strati e coi loro sassolini, rossi o di altri colori. In questo preciso momento il sassolino rosso si illumina di una luce che sai solo te, e comincia a soffiare una bava di vento che somiglia ad un filo tirato fra due punti. Ad un ponte. E ti ci attacchi a quel filo o a quel ponte; ti ci sospendi. Sotto c'è un fiume; ad un certo punto ti lasci andare. E il fiume ti inghiotte.
Ti ritrovi con il culo per terra, accanto al sassolino rosso. È lì. Ti alzi e te ne vai, scuotendoti la terra o la mota dai pantaloni. Scuotendo il capo con una specie di sorriso che assomiglia a un ghigno. Ed è proprio in quel momento là che, un giorno.
martedì 23 febbraio 2010
La luna

Ci starebbe bene, a questo punto, un bel ripensamento. Sarebbero le serate giuste. Il bilancio, i ricordi, gli episodi, le considerazioni...ma non ce ne ho la minima voglia. Sto lì sulla soglia, a guardare i tre pini in quella specie di giardino pensile che ho sopra casa, il gatto è per gli affari suoi e la luna c'è e non c'è. E ci starebbe bene, allora, che scorressero le nuvole in un cielo mobile; ma le nuvole se ne stanno ferme, compatte. Fumo. Quasi quasi me ne accendo un'altra. Quasi quasi tiro giù i piedi dalla soglia e percorro l'universo cortile; mi accorgo che comincia ad esserci qualche finestra aperta. Me ne accorgo dall'aumento dei rumori di televisione; ondeggia un pino nell'assenza pressoché d'ogni cosa. Mi sorprendo a cercare d'individuare di che trasmissione si tratti, forse un film. Una voce grassa, sguaiata.
Avevo detto di voler essere un ponte di sogni, e sono in un cortile in mezzo a gigantesche pozzanghere che rifletterebbero la luna, se comparisse. Avevo sognato un sacco di cose e mi ritrovo qui, a desiderare uno squarcio nel cielo. Che non ci sarà. Non ci sarà nulla, almeno per stasera. Vedo accendersi una luce a una finestra, e poi spengersi dopo pochi attimi; percepisco qualche rumore piacevolmente sconosciuto. Magari, sulla Luna, c'è un altro me stesso su qualche soglia. Tutto coperto. Aspetta il suo gatto lunare, si fuma la sua sigaretta Selen Blu. I cortili della luna sono come questo, e tutti quanti siamo là, tutti noi mestessi, ad attendere primavera, bellezze e abbandoni che ora sono ricoperti da una coltre di nuvole.
Quello sul piedistallo risponde a MTR

Bah, che dirti. Innanzitutto che non eri certamente il solo ad essere “chiamato in causa” o roba del genere (odio abbastanza questa espressione giuridica, ma non fa niente). Gli è che l'altro giorno, aprendo e leggendo i blog che più o meno mi interessano -e li leggo, non li “scorro”- era tutto un “sanremare” che mi ha dato, sinceramente, molto fastidio. E infatti mi rendo conto di avere scritto un post discretamente fastidioso, dal quale deriva questa tua risposta altrettanto fastidiosa. Prima di tutto, però, vorrei anch'io tranquillizzare te e chiunque legga: non ho nessunissima intenzione di fare “paternali” a chicchessia, e non mi ritengo né più bravo né niente. Semplicemente, esprimo. “Esprimere” è la stessa parola di “spremere”, etimologicamente. Cerco di spremere tutto ciò che mi sento, senza preoccupazioni di sorta; ma siccome è quel che fai anche tu, non mi ci dilungo.
'Sta cosa di Sanremo mi spreme rabbia. Ma non ho mai parlato né di insipienza, né soprattutto di “mediocrità”. Anzi, se ben mi ricordo, qualcun altro mi disse una volta che amerei “circondarmi di mediocri”. Lungi da me. Ma non perché io frequenti chissà chi, ma perché non considero le persone che frequento come mediocri. Tutt'altro. Proprio per questo mi ha dato fastidio vederne diverse (e, ripeto, non mi riferisco soltanto a te!) scervellarsi su Sanremo. Cosa, è vero, sulla quale ho scritto delle cose anch'io, facessero “ridere” o meno. Non ritengo di avere il “dono della consapevolezza”, come lo chiami tu, ma almeno di una cosa sono cosciente: che la rabbia (ed il fastidio) vanno e vengono. Quel che un giorno non fa rabbia e induce a scrivere cose divertenti, un altro giorno la fa e induce a scrivere cose fastidiose. Questo non significa che uno si metta su un piedistallo e giudichi a dritta e a manca, oppure che le cose che faccio io vadano bene e quelle che fanno gli altri, no. Le cose che si fanno vanno tutte bene, così come va bene criticarle nei modi e nelle forme che si vogliono. Per esempio, va benissimo che tu lo stia facendo, e va benissimo anche che io ti stia rispondendo per chiarire alcune cosette.
Valutare la mia “paternale”? A parte il fastidio e lo sconcerto di cui ti parlavo prima, valutala un po' come ti pare. Del resto mi sono ampiamente “sbollito” anch'io, solo che avevo già provveduto prima a rimuovere il tutto non occupandomene minimamente. E non parlerei nemmeno di “ragione” o “non ragione”, ma di un'altra cosa ben più importante. Tu sei libero di considerarti come ti pare, ma io non ti considero affatto un “Signor Nessuno”, a prescindere da quante persone leggano il tuo blog. Per me non sei un “Nessuno”, ma Red. E quel che scrivi, quali che siano i tuoi impulsi, per me è importante non da ieri. Lo è fin dai tempi dei newsgroup e delle liste. Vorrei fartelo presente, perché a volte quel che sembra un “fastidio” è invece mancanza assoluta di indifferenza. Quel che scrivi non mi è mai indifferente, e a volte può provocarmi fastidio. Così come quel che scrivo io può provocarlo in altri. Non è neanche la prima volta che te lo dico, fra l'altro. Nulla di nuovo. E credo che sia del tutto normale.
Che su un blog si possa scrivere quel che si vuole, è palese. Tra l'altro, anticipando un po' il prosieguo della risposta, uno dei motivi per cui ho eliminato i commenti da “AN” (che è anche la sigla di Ancona, per fortuna) è proprio per eliminare del tutto anche le tracce, le scadenze, chi ti rompe i coglioni o ironizza se non mandi avanti il raccontino. Gli eventuali commenti mi siano fatti sul muso (come diverse persone hanno fatto, peraltro); per questo c'è indirizzo e numero di telefono.
E veniamo alla parte più interessante, quella in cui mi sento io “chiamato in causa”. Prima di tutto ti dirò: io avrò fatto una fastidiosa “paternale”, d'accordo. Tu però, nella tua “ramanzina di risposta”, di lezioni di vita, di comportamento e di educazione ne hai fatte altrettante. Come tutti quanti, riporti alla tua vita e al tuo comportamento. Che hai. Ne dai, di lezioni, come ne do io, come ne dà Pinco Pallino e Tiziocaio de' Semproniis. E ritengo che sia tutt'altro che sbagliato. Se uno non si esponesse, se uno ritenesse di non avere nulla da dire agli altri, tanto varrebbe che se ne stesse bello zitto. Poi, le reazioni sono liberissime; ma non crederti esente per decreto, o “motu proprio”, dal fornire esempi. Ne fornisci nel momento stesso in cui racconti di te, di quel che fai, di quel che senti, di quel che vorresti o non vorresti. Non c'è bisogno di nessun fischio. Però, per piacere, almeno con me non giocherellare all' “inconsapevolezza”. Le bacchettate, quasi sempre giustissime, le tiri pure tu a dritta e a manca, ed in modo del tutto consapevole. Altrimenti non lo faresti. Le tiri perché ti va di tirarle, hai degli ob(b)iettivi e cerchi di colpirli. Io non credo che niente, e ribadisco niente, possa avvalersi del pretesto dell'inconsapevolezza. Una cosa la si fa a ragion veduta, sempre. Questi sono blog dove si scrive liberamente e pititì e patatà, ma non sono roba tipo “scrittura automatica”. Sono anche blog dove si prendono delle posizioni. E prendere posizioni senza criticare o “bacchettare” non è possibile e, soprattutto, non è “inconscio”.
Sulla storia dei commenti eliminati e della “Verità assoluta” che ti puzza, e che promanerebbe da una mia presunzione, vorrei ripetere che qui, su questo blog, in realtà i commenti sono più liberi che altrove. Sono semplicemente spostati. L'interazione viene spostata al contatto diretto, e alla decisa volontà di averlo. Ad un certo punto non ne ho potuto più di “anonimi”, di “nick” e compagnia bella; non ne ho potuto più di tutti i “giochini in rete” e, in un certo senso, mi sono riappropriato di me stesso. Del tutto sinceramente, poi, ti dirò che non desideravo anche più che due o tre persone ben precise avessero ancora a infestarmi il blog, e la cosa ha avuto il suo peso. Poi mi ci sono trovato bene, senza rumori di sottofondo. Tenendo presente, e ti invito a farlo, che eliminando i commenti non ho eliminato soltanto i rumori sgradevoli, ma anche quelli gradevoli. Il che è, direi, l'antitesi della presunzione. Tutti son buoni a dire che non gliene importa niente dei commenti, ma difficilmente rinuncerebbero a una lode, a un applausino, a una risata, a un'approvazione. Io ci ho rinunciato, e che per questo mi si dia non solo di presuntuoso, ma addirittura di portatore di “verità assolute” mi sembra piuttosto buffo. Senza contare che chiunque, come hai fatto tu, mi può rispondere (criticare, infamare, approvare, deridere, lodare...) dal suo blog. Cosa che ritengo degna e interessante, perché continuo a credere che i blog siano fatti per questo e non per essere una noiosa appendice del dizionario delle citazioni, o antologie di poesie in gran parte pallose come un due novembre, e via discorrendo.
Quanto al resto, vorrei dirti che il “fughismo” di cui parlavo non è esclusivamente rivolto a te. Sulle tue motivazioni, sui tuoi “valigioni di cazzi tuoi” e su tutto il resto non metto bocca. Ma continua a darmi noia, in generale, il “fughismo”. Coraggio, pigrizia, codardia? Fanno parte, queste cose, giustappunto del valigione di cazzi tuoi; ma conosco una marea di francesi che si vergognano di essere francesi, di tedeschi che si vergognano di essere tedeschi, di argentini che si vergognano di essere argentini. Non so cosa voglia dire “sentirsi italiano”, ma non saprei nemmeno cosa voglia dire “non sentirvisi”. Quel che vorrei sentirmi, è esclusivamente me stesso. Dovunque sia stato e dovunque sia. E già questo non è stato, almeno per me, sempre facile. Tutt'altro. Me stesso ritengo di esserlo, o di non esserlo, ovunque io sia. Un posto vale l'altro. L'Italia non è, in questo, un posto peggiore di altri. Ci sembra tale perché ci viviamo, come un francese può avere i medesimi sentimenti nei confronti della Francia, o uno spagnolo della Spagna. La reazione del “voglio andarmene altrove” però mi ha generalmente, e sinceramente, stufato. Il fatto che abbia preso spunto da una tua affermazione, non significa che fosse rivolta specificamente a te. È rivolta, anzi, a tutta quella pletora di italianelli cui basterebbe che non ci fosse più Berlusconi & Co. perché tornasse loro la voglia di stare qui, e di darsi un pochino da fare. È rivolta a chi, di fronte alla merda di questo paese, vorrebbe rimpiazzarla con la merda di un altro. Tanto per citare sempre quel solito signore con la barba (che non è gesù cristo, eh!): “Ti accorgerai da solo, nemmeno dopo tanto, che la noia di un altro non vale”.
Vorrei poi sorvolare, ma purtroppo non posso, su quelle poche righe dove mi dici che io “insegnerei a vivere e a comportarsi”, cosa che farei “un po' troppo spesso, magari inconsapevolmente”. E dagli con l'inconsapevolezza! No, caro Red, invece lo faccio consapevolmente. Sempre. Soprattutto non insegno un cazzo, non sto su un “piedistallo” né con la Daniela, né col CPA né con niente, e dirmi una cosa del genere è semplicemente da stronzi. Cosa che ti dico senza problemi, dato che tutti abbiamo dentro una componente di stronzaggine, tu ed io compresi. Ma cosa ti sei sentito, “attaccato” oppure accusato di errori? Ma che ti ha dato di balta il cervello? Allora cosa vuoi, che stia zitto, magari “inconsapevolmente”? Che racconti soltanto storielline, che non mi esprima più sennò c'è il rischio, magari inconsapevolmente, che qualcuno mi dica che sto sul piedistallo e do lezioni? Faccia un po' quel che vuole, questo qualcuno. Tanto zitto non ci sto, e borda in cùlo. Finiranno altre amicizie, o presunte tali? E pazienza. Ho già visto, del resto, com'è andata con diverse “amicizie”, di quelle per cui basta mezza parola su una mail finita misteriosamente in pubblico per scatenare le virgolettature. Di queste cose non mi curo più, e te lo devo dire in tutta sincerità. Ognuno tragga le proprie conclusioni, faccia i propri ragionamenti e si comporti di conseguenza.
Quanto a Facebook, vorrei ricordarti che tu, a differenza mia, non hai avuto chi ti ha fabbricato una finta pagina per sputtanarti, infamarti e prenderti per il culo davanti a mezzo mondo. Qualcuno, peraltro, molto ben informato su di te. Per il resto, conosco e sto bene con decine di persone che hanno la loro bella paginetta Facebook. Ma lo odio, sì. E di un odio viscerale. Odio quel mezzo che permette a chiunque di fare una cosa del genere, cosa che io non avrei nemmeno concepito di fare; e il sospetto che si tratti di persone che ben conosco accresce ancora quest'odio. La trovo una cosa schifosa, e trovo schifoso che non ci si possa fare niente (per questo ebbi la reazione della “polizia postale”, a suo tempo). Tutto questo, caro mio, tu non hai avuto da viverlo. Non sei stato sbeffeggiato davanti a migliaia di persone. Non catalogo affatto chi si serve di quel mezzo (e anche qui, vorrei dirtelo, mi hai dato -e per nulla inconsapevolmente- una “lezione di vita e di comportamento”), ma catalogo il mezzo per quello che può essere: un'arma per ferire. E magari anche per ammazzare, perché no. Ho imparato poi a sbattermene i coglioni, e non direi di passare il mio tempo, anche sul blog, a parlare di Facebook. Ne parlo quando mi va, e ne parlo male. Ma forse, chissà, starò davvero diventando “asociale”.
Il mio “volontariato alla CRI”, ti annuncio, non è più tale. Non è la CRI, e non è più nemmeno volontariato. E' un lavoro con orari massacranti. Sono stato costretto a farlo perché delle traduzioni del cavolo di cui campavo non se ne vedevano più nemmeno l'ombra, e per scrivere questo post ho rinunciato a mangiare nella pausa. La mia “preparazione” e la mia “cultura” mi hanno portato a questo: ad essere un autista di ambulanze per euro 1050 al mese. Poi però mi devo anche sentir dire che do lezioni sul piedistallo perché non mi piace chi vuole “emigrare”, e mi devo beccare i commentini con gli “eheheheheheheheh” cretini del signorino dell'Agenzia delle Entrate. Beh, mi farò coraggio a modo mio. Ti saluto e torno a lavorare. Ma ti pregherei di un piacere. Se hai qualcosa da dirmi ulteriormente, telefonami. Altrimenti scrivi di mondiali e di ippica, certo che ti leggerò anche se l'ippica è uno sport che mi fa venire il latte ai coglioni.
Tutto questo, naturalmente, quando ti sarà passata la sbornia, perché in fondo voglio ritenere che il tuo post sia stato frutto più che altro di una sbronza colossale. Forse questa lunga spatafiata avrebbe potuto essere riassunta più opportunamente con un bel posa ir fiasco!, ma tant'è. Mi ha dato modo di spiegare alcune cose, e anche di togliermi un par di sassolini dalla scarpa; non è poco.
Post Scriptum. Red mi ha ulteriormente risposto qui, e lo ringrazio.
lunedì 22 febbraio 2010
Austin, Texas
Ma come si fa a non amarla, l'America?
Una volta, a una piola, ci arrivai persino con una maglietta: Don't Mess with Texas, c'era scritto.

Peccato, l'ho persa. O forse è lei che ha perso me!
Intanto tutti più o meno

Intanto tutti, più o meno, si trovavano davanti ai teleschermini dell'aborrita tivvù; o quantomeno con essa si rapportavano. C'era, giusto sabato sera, la finale del Festival di Sanremo con le sue belle canzoncine, tra le quali una che mi sono divertito a parodiare. Forse la mia parodia è ancora più idiota dell'originale, ma non è questo il problema. Il problema, a mio parere, è vedere che cosa ha suscitato il suo cammino sanremese, il suo ripescaggio, il suo secondo posto finale. La parola che più mi viene a mente è psicodramma; e, mi dispiace, io non sono affatto portato agli psicodrammi. Su quella stupidissima canzone e sui suoi imbecillissimi interpreti ho detto la mia e ho fatto la parodia (fa pure la rima!); ma domenica mattina, quando a un'ora assai tarda ho acceso il computer e ho appreso la feral notizia, ho avuto francamente di che grattarmi la pera.
Nel paese di Bloggherìa è tutto un sanremare, tutto un filibertare, tutto un pupare. Si va dai colloqui post-mortem con Luigi Tenco a improbabili confronti, da "Italie oramai scomparse" ai glossari sanremesi, dai "post con più fan di Sanremo" alle immancabili vergogne di essere italiano, condite con le altrettanto immancabili dichiarazioni di esilio volontario, o coi rimpianti di non averlo fatto prima. Insomma, ovunque ci si muova, è tutta una geremiade sanremese. Tutti si vergognano, tutti sono indignati, tutti sono sbigottiti, tutti sono schifati però sabato sera erano davanti all'apparecchietto delle meraviglie a far parte di quel 53% di italiani che guardavano il Festival. Io non ero fra quelli. Ero a Alessandria, in un locale angusto all'angolo tra via Verona e via Santa Maria di Castello. Non c'ero mai stato, a Alessandria. Avevo, alle medie, una professoressa di storia nativa di quella città che passò tutti i tre anni dalla prima alla terza a dirne peste e corna; ma in fondo ho visto posti ben peggiori, e in certi casi ci ho anche vissuto non poco.
Poteva, poi, essere Alessandria o qualsiasi altra città dove andare. Poteva essere anche casa mia; non lo avrei acceso comunque quel televisore di merda. Che i filiberti e i pupi cantassero quella popo' di canzone lo si sapeva da tempo; tutto il tempo necessario per pigliarla per il culo prima, e per ignorarla poi assieme a tutto quel ridicolo baraccone teletrasmesso. Per passare la sera di sabato 20 febbraio 2010 in altri modi; invece no. Ci sono cascati tutti quanti. Ci siete cascati, anzi. Ho come l'impressione che i filiberti emanueli e i pupi vi abbiano menato per il naso alla grande, cari miei. E bisogna che ve lo dica, che abbiate poi guardato o meno il Festival. Siete stati, e siete, il più grandioso veicolo pubblicitario di quella canzone. Con grande amarezza, devo dire che è stata un'operazione davvero ben congegnata.
E allora, ditemi un po', come mai desiderereste così tanto emigrare? Ve lo dice uno che ha passato qualche bell'anno all'estero, generalmente in postacci, sognando praticamente in ogni momento di tornare in questo paese di merda. E constatando che tutta 'sta voglia di andarsene lontani non solo non serve assolutamente a un cazzo, non solo somiglia terribilmente a uno stantio esercizio retorico, ma anche viene generalmente espressa da gente che al massimo ha fatto qualche gita organizzata, qualche vacanza, qualche giretto più o meno cospicuo nelle solite londre, nelle solite barcellone, nei soliti mèssichi e nei soliti luoghi dell'immaginazione. Fughe, reali o immaginarie; ma nel frattempo, finché non si fugge, il 20 febbraio si guarda Sanremo per indignarsi per una canzonetta idiota. E mi sembra, questa, una cosa tremendamente italiana. Che più italiana non si può. Andateci un po' per davvero, a vivere all'estero. Accorgetevi una buona volta che il problema non è "vergognarsi di essere", ma far qualcosa di concreto perché tale vergogna abbia non dico a cessare, ma perlomeno a moderarsi.
Io mi sarei vergognato, sapendo bene che cosa si cantava a Sanremo (e non soltanto la canzone di filipupo), di accendere la tv e guardarne anche un solo minuto. Mi sarei vergognato, anche non guardandolo, di parlarne e di fungere così da veicolo. E così non l'ho fatto. Sono andato a Alessandria, a vedere un concerto di canzoni un pochino differenti. Ce ne sono, di questi concerti, e di queste canzoni, anche vicinissimi a voi. Basterebbe cercarli. Basterebbe smuovere il culetto. Basterebbe comunque non sottostare a quel che viene imposto, cari i miei italiani che tanto vi vergognate. Basterebbe restare qui, in questo paese, senza nessuna vergogna e facendo altro, senza riempire i vostri blog di stronzate su Sanremo. Una rivoluzionaria indifferenza, magari senza quell'insopportabile insalata di indignazione, rassegnazione e fughismo del cazzo che sta veramente cominciando a farmi venire il varicocele. C'è, invece, da stare dimolto qui e da sbattersi, giorno dopo giorno. Altrimenti suggerisco un rimedio che preserverà da ulteriori pupifiliberti: il suicidio. Di morti alla tv ce ne sono fin troppi, e a me piace invece avere a che fare con dei vivi che dall'indignazione per cose un po' più degne di una canzonetta traggano la rabbia di vita che serve per fare almeno una piccola rivolta, che si potrebbe chiamare una rivoltella.
Ah, specifico che quest'ultima non è mia. L'ha detta il cantante di Alessandria, in una sua canzone scritta da poco. Gliel'ho rubata, ma credo ci stesse bene. Mi scuserà se legge. In ultimo, a chi rimpiange magari il "vecchio Sanremo" come se fosse stato chissà cosa o tutto Endrigo o Tenco, ricorderei volentieri che nel 1970 si sentivano sul palco dell'Aristronz cosine come quella qui sotto, di un reazionarismo schifoso, odioso, stupido. In fondo, pupoberto non ha fatto che rinverdire la tradizione, quella vera. Altro che "Italia oramai scomparsa".
mercoledì 17 febbraio 2010
Fermate

Musica di Fabrizio de André
Dall'Antologia di Greve River di Edgardo Leo Maestri
Da bambino volevo andare ai Ciliegi
quando rossi di frutti li vedevo a Scandicci,
l'autobus, però, ci aveva scaricati
giù nel viale Nenni in mezzo ai baraccati.
Un sogno, fu un sogno, ma non durò poco
per questo giurai che avrei fatto il tranviere
e non per un dio, ma nemmeno per gioco:
perché ai Ciliegi s'andesse a tutte l'ore,
perché ai Ciliegi s'andesse a tutte l'ore.
E quando tranviere lo fui finalmente
non volli tradire il bambino per l'uomo
e salivano in tanti, e si chiamavano "gente",
dai Ciliegi andavano alla stazione.
E i colleghi d'accordo, i colleghi contenti
nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare
mi dirottavan sul tràmme i nullatenenti,
con la sentenza in faccia, e per tutti era uguale:
derelitto, immigrato, incapace a pagare.
E allora capii, fui costretto a capire
che fare il tranviere è soltanto un mestiere,
che il biglietto non puoi regalarlo alla gente
se non vuoi ritrovarti ridotto anche te male,
se non vuoi che il sistema ti pigli per fame.
E il sistema sicuro è pigliarti per fame,
nei tuoi figli, in tua moglie che vogliono i' Sùvve
perciò, dopo aver chiuso del tram le portiere
dicevo ai passeggeri: "Si paga al tranviere".
E un giudice, quello della canzone sul nano,
mi spedì a fare un viaggio sopra un cellulare,
la sola fermata era a Sollicciano,
eh sì, ero un tranviere un po' particolare
però quando esco ritorno a guidare.

Domani 18 febbraio è nato Fabrizio De André.
martedì 16 febbraio 2010
Seppelliti dalle risate

Dopo questo primo seppellimento, gli aquilani sono stati ripetutamente seppelliti da altre cose che, volendo, sono ancora più tremende del terremoto.
Sono stati seppelliti dal più gigantesco e ignobile spot elettorale che si sia mai visto in questo paese. A macerie ancora fumanti è arrivato Lvi, con aria grave e compunta, serio, vestito di scuro, scravattato (la cravatta non si addice alle emergenze) ma con la dolcevita a collo alto. Credevano di averlo messo alle corde con un po' di gossip, di disavventure coniugal-sessuali e di cazzi ritti di Topolanek, e con qualche decina di domande. Gli è bastato, invece, un terremoto di una magnitudo che, in paesi civili, avrebbe provocato soltanto qualche ferito. Gli sono bastati i consigli dei ministri tenuti in una città dove era crollato persino il palazzo del governo, la Prefettura. Gli è bastato apparire, farsi riprendere dalle sue sei televisioni e promettere, come sempre, mari e monti. Addio Noemi, addio Veronica, addio feste a Villa Certosa, e addio anche alle domandine di Repubblica. Addio alle raccolte di firme e a tutte le inutili boiate del genere. Seppelliti gli aquilani sotto un mare di provvidenzialismo. Ce ne saranno stati parecchi, anche fra di loro, che in quei giorni hanno pensato, convinti: menomale che c'è Lvi.
Seppelliti poi dal G8 spostato, sempre da Lvi, dalla Maddalena all'Aquila. Seppelliti dai padroni del mondo e dalle loro ladies, tra beneficienze, visitine ai monumenti crollati e gli inutili rituali di quel periodico summit di assassini planetari. Intanto, alla Maddalena, stavano succedendo certe cosine di cui si comincia a sapere un po' giusto in questi giorni. Intanto gli aquilani venivano espropriati della loro città, della loro storia e della loro vita come comunità per un piatto di lenticchie. Qualche casetta ben grancassata dai Vespa, dai Minzolini, dagli emilifìdi. Esibizioni di facce sorridenti, dopo il classico momento del dolore coi funerali delle vittime.
Calate nella terra proprio mentre, a loro insaputa, venivano pure seppelliti dalle risate. Bisogna muoversi, non c'è mica un terremoto ogni giorno!; e giù risate, risatine, risatone. Ma qui non era come nel vecchio slogan, che voleva mettere in risalto il ridicolo del potere. Qui si trattava, e si tratta, di un potere che ride sulla morte e sulla rovina dei sudditi, mentre i sudditi stessi lo osannano. Si tratta di capi di "protezioni civili" che di civile, ce ne accorgiamo, non ha niente. Di direttori generali dei lavori pubblici, di costruttori, di tutto un sistema che non domanda più sterili filosofie, analisi teoriche tanto più cretine quanto ambiscono ad essere "approfondite" o indifferenze più o meno disilluse. Si tratta di un sistema che ci costruisce le case, gli ospedali, le scuole, e che lo fa fregandosene se crollino o se stiano in piedi. Di un sistema che ci dovrebbe proteggere, e che invece protegge soltanto se stesso e il suo profitto. Di un sistema i cui lavori pubblici, oltre a dare il colpo di grazia a ciò che ancora resta di questo paese, sono tutt'altro che "pubblici". Di un sistema le cui privatizzazioni ci tolgono tutti i beni primari per trasformarli in fiumi di denaro, appunto, privato. Tutte cose che hanno un'incidenza immediata sulla nostra vita. Sarebbe bene ficcarselo nella testolina prima di rinchiudersi in storielline avulse dalla realtà.
Ce n'è voluto di tempo, prima che gli aquilani, finalmente, si accorgessero di quel che veniva combinato sulla loro testa, sulle loro macerie, sulla loro morte. Prima che rialzassero il capo, prima che manifestassero, prima che formassero collettivi di riappropriazione. Prima che cominciassero a mandare alla malora tutto il vomitevole giochino di quei signori che ridono. Non è mai troppo tardi; ma tutto rimarrà inutile senza una cosa fondamentale. Basilare. Urgente.
Quei signori là non devono più dire di proteggere. Non li vogliamo più vedere con le loro dolcevita, coi loro prelati benedicenti, con le loro sfilate, coi loro "consigli", coi loro summit, coi loro maglioncini blu impataccati di stemmi, con le loro telefonate, coi loro affari di merda, con le loro risate. Non ce ne deve fregare niente né delle loro puttane, né delle dieci domandine di giornaloni di questa ceppa di minchia. La domanda da rivolgere loro è una sola:
giovedì 11 febbraio 2010
Per la giornata dell'Oblìo.

Come data propongo il 16 giugno. Il 16 giugno 1971 mio padre, vicino al suo ufficio in via dell'Agnolo, si levò una scarpa perché era stato preso da un tremendo prurito al piede sinistro. Si levò anche il calzino e si dette una grattata micidiale e ristoratrice alla pianta del piede; poi si rimise la scarpa, ma si dimenticò di rimettersi il calzino che aveva appoggiato a un cestino della spazzatura. Tornò a casa, e mia madre si accorse che aveva un calzino solo; "O Alberto!", disse. "Ma l'altro calzino dove lo hai messo?!?" E lui: "O Luciana, mi prudeva un piede, mi so' levato la scarpa e i' calzino e me ne so' dimenticato".
Il 16 giugno, quindi, si provveda a dimenticare tutto quanto, e specialmente le varie "giornate della memoria" che ci sono propinate oramai a cadenza mitragliante. Anche perché sono "giornate" in cui, in realtà, la memoria viene mandata semplicemente al macero. Sono "giornate" che sono fatte per tutto, fuorché per il reale ricordo. Sono vomitevoli esercizi di pensiero unico. La memoria è tale solo quando risiede profondamente nella coscienza individuale e collettiva; quando, invece, è una sterile imposizione di obblighi selettivi, serve soltanto a nascondere la realtà attuale; e, quel che è peggio, a nasconderla istituzionalmente.
Si dimentichino quindi i ventisette gennai, e tutti gli "olocausti" fatti solamente per propagandare le malefatte di uno stato assassino e imperialista come Israele, le sue occupazioni, le sue guerre e l'impossibilità di formulare qualsiasi tipo di critica e di opposizione nei suoi confronti. Il ventisette gennaio non rappresenta nessuna "memoria" per coloro che sono morti, e non importerebbe in questo che fossero stati milioni o uno solo. Rappresenta esclusivamente una vetrina mondiale per uno stupido e feroce nazionalismo ottocentesco, il "Sionismo", che tuttora non solo persiste, ma che si vorrebbe inculcare come dogma planetario. Tutto ciò, il 16 giugno, dovrà essere dimenticato. Si dimentichi Berlusconi che, vergognosamente, va a vendere il culo come uno schiavo dentro al parlamento israeliano, giustificando pubblicamente una guerra che ha ammazzato centinaia di persone innocenti. Si dimentichino i falsi "negoziati di pace" che durano da decenni. Si dimentichino tutte queste bassezze; le si dimentichi e lo si gridi pubblicamente. E a chi dice che questo tipo di "memoria" imposta impedisce che "certe cose accadano ancora", si risponda che certe cose (nazismi, razzismi, lager) trovano terreno fertile proprio sull'arroganza armata fino ai denti di chi si serve delle vittime di un tempo per compiere e giustificare le repressioni e le stragi di oggi.
Si dimentichino, il 16 giugno, i dieci febbrai e l'invenzione delle "Foibe" cui deve sottostare, per compiacere una certa parte politica, anche un uomo la cui "funzione istituzionale" dovrebbe essere di rappresentare tutto un paese. Perché anche questa "giornata della memoria", in realtà, è fatta per nasconderla totalmente. È fatta per nascondere quel che è successo prima del 1945, a cura di un regime fascista e nazionalista che aveva "italianizzato" a forza terre che italiane non erano. Che aveva cercato di sradicare lingue e culture intere. Che aveva represso, incarcerato, internato, ucciso. Vale a dire, gli effetti normali di ogni nazionalismo schifoso. Il nazionalismo, quando poi viene sconfitto da chi prima era stato ridotto ad un suddito di serie B, genera reazioni terribili. Le cosiddette "foibe" sono state il prodotto perfetto di quel nazionalismo e delle sue malefatte. È stata, probabilmente, una reazione anche abbastanza blanda in confronto a vent'anni di oppressione quotidiana; ma quei vent'anni, quelli no, non formano oggetto di "memoria". Tutt'altro. Vent'anni di fascismo che hanno prodotto quel che hanno prodotto tutti i nazionalismi. Sradicamenti, migliaia di morti, espulsioni, pulizie etniche, vendette. Anche chi è morto nelle "foibe" è stato vittima di quel nazionalismo. Le vie, le piazze, i larghi che sono stati un po' ovunque intitolati ai "Martiri delle Foibe" dovrebbero essere intitolati alle vittime di tutti i nazionalismi: quella sarebbe vera memoria. La "memoria" del 10 febbraio, biascicata anche da Napolitano che si permette come sempre di essere offensivo e irriguardoso verso due altri stati sovrani che ebbero a patire due decenni di durissima oppressione fino ad essere (nel caso della Slovenia) addirittura inglobati come "provincia di Lubiana", dev'essere eliminata. Dimenticata. Rimossa.
E, il 16 giugno, si dimentichi anche l'"otto marzo" e la cosiddetta "Giornata della donna". Una festicciola idiota che oramai è diventata come l'Halloween benevolmente concesso a signore e signorine per farsi una pizza fra di loro, con la mimosina regalata la mattina da chi per i restanti 364 giorni dell'anno le considera generalmente come fiche con inutile carne attorno. Da chi, per i restanti 364 giorni dell'anno, e in svariati casi anche lo stesso otto marzo, le stupra domesticamente, le fa lavorare al nero in scantinati, le fa prostituire a forza, le ammazza assieme ai figli per i suoi fallimenti personali, le mercanteggia, le opprime in ogni modo possibile e immaginabile. Nessuna memoria per questa data oramai vuota, ché la memoria della sua origine è oramai persa, o stata fatta perdere. Sia, allora, dimenticata. Principalmente dalle donne che sottostanno annualmente al giochino, come macchinette, come bamboline cui si permette una serata di "evasione". Le mimose vengano lasciate sugli alberi. Ai mimosi si attacchi per le palle il sor padrone che fa mobbing, il maritino che vuole la cena o la scopatina, il fidanzatino che già a sedici anni comincia a considerare la fidanzatina come una sua proprietà, il sor parroco che propaganda le virtù da madonnina.
Il 16 giugno si manifesti il proprio oblìo di tutte queste ignobili stronzate, la volontà di spedirle nel dimenticatoio personale e della storia, l'intenzione di non ricordare più soltanto quel che vorrebbero farci ricordare a loro esclusivo e sozzo tornaconto. Si appendano calzini alle finestre, o meglio ancora li si lasci, dimenticati, appoggiati ai cestini della spazzatura. Oppure non si faccia proprio un bel nulla di "simbolico", ma si dimentichino nel profondo tutte queste false "memorie" del potere; ché il potere desidera sempre e soltanto ricordare una cosa sola. Che tu sei un oggetto. Di sesso, di marketing, di mode, di voto, di pubblicità. Auschwitz, la foiba e la mimosa non sono diverse dalla carne Simmenthal, dal Dash o dalle magliette reclamizzate con lo slogan "Sii stupido". Questo è precisamente il loro proposito. Che tu sia stupido o stupida. E allora dimenticalo. Scordalo.
martedì 9 febbraio 2010
Itaglia, amore loro!

E allora, come dire, mi sono premurato di riscrivere leggeremente il testo della canzoncina sanremese, in modo che rispecchiasse un po' di più la realtà delle cose. Poerannòi. E non voglio dire altro, non mi riesce.
dove succede di trombarsi madre e figlia: evviva la famiglia!
Io credo nelle tradizioni di un popolo che si vende
a papi, duci, calciatori e butta a mare chi non ha niente.
(E. Filiberto) Io credo nella coca ma non disprezzo un bel razzone,
vendo scarpe, tifo Giuve, e ho una faccia da cazzone.
Sono l'immagine perfetta di quest'Itaglia merdaiola,
fatta di idioti, di veline, enalotti e gente forcaiola.
(L. Canonici) Sì stasera sono qui per dire al mondo e a Dio, Itaglia e Padrepìo!
Io, io non mi stancherò di dire al mondo e a Dio, Itaglia e Ciancimìo!
(E. Filiberto) Ricordo quando ero bambino, ci davano dei boia,
chiudevo gli occhi e sentivo le grida: "A morte la casa Savoia!"
(Pupo) Ventennio e quel Beccaris, la fuga e il paparino
che traffica le armi e ammazza il ragazzino...
(L. Canonici) Sì stasera sono qui per dire al mondo e a Dio, Itaglia e Padrepìo!
Io, io non mi stancherò di dire al mondo e a Dio, Itaglia e Ciancimìo!
(Pupo) E noi crediamo nel denaro, nelle mafie e questi stronzi
Ci applaudono a Sanremo, proprio un popolo di gonzi!
(E. Filiberto) Sì, stasera sono qui per dire al mondo e a Dio, Itaglia e Padrepìo!
Su, Pupo, passa la cannuccia che mi faccio un tiro anch'io!
Obreros

Le telefonate non si poteva aspettarle, perché le cabine non ricevevano. Si poteva soltanto farle, munendosi originariamente dei gettoni scanalati, e poi delle monetine da dugento lire. Continuarono però, e per un bel pezzo, a circolare anche i vecchi gettoni, che venivano usati comunque come moneta; l'Italia è l'unico paese al mondo dove, negli anni '70 del secolo scorso, sono esistite valute parallele a quella ufficiale, e comunemente accettate. I gettoni telefonici e i miniassegni. Avevano voglia i negozianti a mettere all'ingresso avvisi con su scritto: “Non si accettano gettoni”: tanto gli toccava accettarli di riffa o di raffa.
A Marina di Campo esistevano due file di cabine telefoniche: una davanti alla Coop sul lungomare, e l'altra nella piazza del Municipio. Specialmente d'estate era un delirio: quando c'era da andare a telefonare, bisognava munirsi di sacchettate piene di una macedonia di gettoni e monetine; non essendo ancora di moda i marsupi, e poiché il famoso borsello a tracolla di quegli anni provocava (giustificatissime) bordate di prese per il culo, s'andava coi sacchetti di plastica. Alle cabine c'erano generalmente, tutte le sere, code in pieno stile sovietico; naturalmente s'andava solo la sera a telefonare, perché costava meno. Le code erano sovietiche solo per la lunghezza; ma nell'URSS erano ordinatissime e rassegnate. Quelle lì, invece, erano pienamente latine con qualche spruzzata di tedesco che ironizzava sull'arretratezza di quel paese di poveri dove nelle case non c'era ancora il telefono. Per il resto, erano gomitate, lamentele, minacce sanguinose a chi telefonava troppo a lungo, botte sui vetri, malori, bimbi che frignavano, e conversazioni per ingannare l'attesa che digradavano rapidamente dal banale all'imbecille. Poi, finalmente, toccava a te. La telefonata al babbo rimasto in città, o alla ragazza che passava le vacanze dai suoi nel Sud. Nel Sud, però, il telefono in casa ce l'avevano eccome. L'Elba, negli anni '70, era ancora più a sud.
Avvenne che, finalmente, a Marina di Campo si decisero a mettere il telefono nelle case. Fu, statemi bene a sentire, nei primi mesi del 1985. Ripeto: Millenovecentoottantacinque. A quell'epoca ero all'università, e mi capitava, con la scusa di preparare qualche esame, di passare qualche volta una quindicina di giorni a casa dei miei, fuori stagione; ovviamente l'esame era un pretesto, e non appena mettevo piede all'Elba con la 127 amaranto mi lanciavo immediatamente nella mia attività preferita: quella di esplorare all'infinito i posti che meglio conosco. Son buoni tutti a esplorare posti sconosciuti, a andare nella Skeleton Coast, nel deserto di Gobi o sul selvaggio picco andino; a me piace esplorare ogni granello di polvere dei posti che mi dicono qualcosa dentro, perché ciascuno di quei granelli mi dovrà restare appiccicato addosso per sempre. A me dell'Armenia o del Karakazzistan non me ne importa una sega, però se mi mettessero bendato nel fossetto che scorre di lato al viottolo fra il Formicaio, l'Orzaio e la Piastraia ci camminerei senza inciampare.
Nell'aprile del 1985, poi, successe quel che agognavo da non so quanto. Mia zia era a Firenze, e la casa era vuota. Non so come, riuscii a convincere tutti quanti che dovevo assolutamente restarmene da solo per preparare non ricordo più quale esame di blutolinguistica glottologica cloridrata; e il permesso arrivò. Caricare la centoventisette, passare per Volterra e Casini di Terra, arrivare a Piombino e avere già tutto in testa. Panini e a giro tutto il giorno, dato che era già aprile e le giornate erano discretamente lunghe. L'esame? Ma vaffanculo. Tanto, poi, chi mi controllava: il telefono non c'era, ed era -vi dirò- un gran bel vivere in un mondo dove nessuno ti trovava. Missing. La telefonata serale dalla cabina, e nemmeno tutti i giorni; non era estate, Pasqua era già passata e le code estive erano ancora ben al di là dal venire. E solo. Senza un cazzaccio di nessuno. Prepararsi una bella cena di troiai davanti alla televisione (la tv c'era, il telefono no; però l'antenna ballava e faceva malissimo). Andare a dormire se t'andava, e sennò di nuovo a giro, a buio, in riva al mare. Allora, come dire, avevo ben ventidue anni. Ci avevo un animo poetico, e inoltre mi piaceva pure un casino tirarmi qualche sega all'aria aperta, sotto le stelle, immaginando cose sconcissime con una sirena.
Il giorno prima della partenza, la doccia fredda. Mi chiama mia zia. “Riccardo”, mi dice, “ma lo sai che vengono quelli a mettere il telefono? Bisogna che tu stia a casa una mezza giornata...”. Per mia zia, quando veniva a casa qualcuno a fare un servizio, che fossero gli idraulici o i trasportatori della legna da ardere, erano sempre quelli. Tale pronome dimostrativo aveva un'accezione semantica che copriva tutta la gamma dei mestieri esistenti; al massimo, ogni tanto, c'era una specificazione tipo quelli delle bombole, quelli della televisione, quelli dello scaldabagno. Costantemente quelli, poi, al plurale, anche se poi ne veniva uno solo; ma per mettere il telefono, con tanto di piantamento dei pali, filo di derivazione e installazione, dovevano essere per forza più di uno. Insomma, addio solitudine. Addio mancato reperimento. Arrivava il telefono in casa, persino al Formicaio. Detti un'occhiata languida alla zuppa di gettoni che mi ero preparato, a mo' di mesto commiato; ma fui subito ripreso da mia madre, che mi ammonì a non usare il telefono per chiamare perché costava. Nel loro sacchetto, i gettoni e le monetine ricominciarono a tintinnare.
E così partii, in quel mese d'aprile di 25 anni fa. Arrivai la mattina presto, e alle dieci ero già a scorrazzare con la macchina ché avevo un vecchio conto da regolare con la maledetta militare del Colle Reciso, che allora era ancora un'infernale mulattiera che riusciva a sderenare anche le vetture preparatissime del Rally, compresa la 124 Abarth Coupé di un mio lontano cugino. Mi riuscì di farla tutta, perdìo, con una 127 scassata. Procedendo ad una media di quindici all'ora, con punte di sette / otto. Sigarette a quintali mentre guidavo col finestrino abbassato, perché faceva già caldo e la storia dei granelli di polvere addosso non è mica un'invenzione: me li volevo pigliare sul serio. Impolverarmi come un maiale. Sbucare da quella stradaccia dove nessuno osava mettere piede, zozzo come un magnano, e magari sperare nel ricompensante sguardo esterrefatto di qualcuno (il che, ohimé, non avvenne: non c'era un accidente di nessuno). E così andò, in compagnia della vecchia gatta priva di un occhio, mangiando la sera squisite delikatessen tipo scatolette di carne Montana fritte nell'olio, bevendo birra, facendo le parole crociate, e soprattutto guardandomi bene dall'aprire i libri che mi ero portato dietro. Del resto, un esame ben più importante mi stava aspettando perché la gatta monòcola era pregna e stava per scaricare una quantità imprecisata di gattini.
Ora, successe anche che arrivò quella mattina alle dieci quando dovevano arrivare quelli del telefono. La sera prima, alle cabine, mia madre e mia zia si erano raccomandate; ero andato a letto alle cinque, alle nove mi toccò svegliarmi e alle dieci, zac, eccoli che arrivano. Puntuali come la morte, ma ero testimone di un avvenimento epocale. Il telefono al Formicaio. Semplicemente impossibile. Da qualunque parte del mondo poteva esistere il telefono in casa, anche nelle favelas di Rio de Janeiro, ma al Formicaio significava l'inizio del XX secolo con qualche annetto di ritardo, facciamo un'ottantacinquina. Il furgone Fiat con la scritta Qualcosa-Tel; a quei tempi le cose che avevano a che fare col telefono finivano tutte in -tel e ancora non erano diventate -com. Ne scendono due operai in tuta, uno alto più di me, e quell'altro più alto ancora; nel cassone del furgone, pali di legno, cavi, arnesi, scatole, cazzi d'ambra, castori impagliati, spine, orinali, prese e una copia delle Ore la cui copertina, dilavata dalle intemperie, mostrava oramai solo una fica pelosa. Tanto, poi, a quello serviva.
“Toh, siamo venuti a mètte' ir telefano”, mi disse uno dei due operai, circa un metro e novantacinque d'ossi; gli risposi che me n'ero accorto, salutandolo al contempo col cenno d'una mano. “Te devi èsse uno studente”, mi disse allora, “perché ci hai l'occhiali”. Cazzo, così, senza preavviso. Già sgamato per via degli occhiali. La classe che subito mi colpiva e metteva le distanze: gli occhiali, il ragazzotto che studia nella casa al mare, e tutto il resto mentre loro sono a lavorà. Forse ci avrei avuto qualcosa da dire, ma dovevo averci una di quelle giornate in cui ero scarsamente sveglio. “Dé, invece di studià vieni a imparà un mestiere”, mi fece sempre quello mentre l'altro, due metri di scheletro, aveva già scaricato i pali e cominciato a fare le buche sul ciglio del campo, terrorizzandomi di toccare il cespuglio di fico slabbrato che fa i fichi più buoni del mondo.
E io ci andai, così, a vederli lavorare, a vedere quel che facevano. In preda ad un sottile senso di inferiorità misto a una voglia di tirargli du' manate nel muso; ma forse non era il caso. Comunque, mentre guardavo e fumavo, continuava a pigliarmi per il culo mentre l'altro stava zitto. Stava nascendo il telefono, Antonio Meucci trionfava anche in quelle lande dimenticate da dio, e si drizzavano i pali del progresso tecnologico. Coi cavi a ciondoloni, però. I pali erano davvero pali, di legnaccio duro; tra di essi, il filo dell'avvenire pendeva gnudo. Per isolare il Formicaio, pensavo, sarebbe in fondo bastato un paio di forbici. Assorto in questi pensieri, quasi non sentivo nemmeno più le continue prese per i fondelli di quell'operaio, che la mattina doveva essersi evidentemente svegliato con qualcosa di traverso e aveva trovato un perfetto studente con gli occhiali per sfogarsi.
Insomma, con tutte le cose che avevo in testa allora, non mi era mai capitato di trovarmi davanti, a tu per tu, con la classe operaia. Così, da vicino. Ce l'aveva particolarmente con gli occhiali, che portavo anche allora perché sono miope fin da quando ho sedici anni. Occhiali voleva dire, credo, libri. Libri voleva dire, credo sempre, non fare un cazzo dalla mattina alla sera. E menomale che, in mezzo ai sarcasmi, quello lì non m'aveva domandato cosa studiavo; gli avessi risposto “filologia germanica” sarei stato finito. “Filologia” mentre quelli stavano piazzando dei fili; come servirgliela su un piatto d'argento. Però li guardavo anche lavorare, e a un certo punto ci fu un piccolo problema. L'ultimo palo era stato sistemato, però il cavo doveva arrivare in casa e nel giardino di mia zia (talmente “pollice verde” da essere soprannominata, fin da ragazzina, la Fiorina) non c'era verso di piantare nulla. Inoltre c'era il susino spuntato quando la mia bisnonna, Dini Giuseppa vedova Dini, cieca, aveva tirato un nòcciolo a casaccio dopo aver mangiato un frutto. Ne era nato un susino, ancora esistente, gigantesco. Aveva superato il tetto. Al Formicaio non c'era il telefono, ma spuntavano susini enormi da un nocciolo tirato da una vecchia cieca; e questo qui non gli è ancora riuscito di inventarlo a nessuno, tranne al Padreterno per chi ci crede.
In mezzo a tutto questo, si fa mezzogiorno; quelli del telefono, gli operai, hanno deciso per un sistema molto pratico, vale a dire far passare il cavo fra i rami del susino -che lo sostiene benissimo. Pali, fili a ciondoloni in mezzo ai rami di un albero, un buco nel muro: l'impianto telefonico più alla 'ioboia della terra. Entrano in casa per fissare la presa, e quello non la smette. Ma tanto chi se ne frega; fra poco hanno finito, se ne vanno, e pazienza. Con mio padre che mi diceva che chi lavora ha sempre ragione, a ventidue anni non ci scherzavo troppo. Stavo zitto; e mentre tacevo, sento un miagolio.
La gatta senza un occhio. Porca puttana, me n'ero scordato; corro di dietro, sul piazzale familiarmente detto Gallina Beach perché d'estate è un forno crematorio ottimo per la tintarella (e per le ustioni), ma a contatto con il pollaio, e nel fossetto c'è lei a cacare gattini. Tranquilla. Lo deve aver fatto chissà quante volte nelle sua vita. Escono fuori e lei li lecca, piano; mi chino. Accanto a lei, casualmente, un pesante stecco di legno, quasi un randello, un rimasuglio della legna da bruciare per l'inverno appena passato. Me ne sto lì mentre sento lavorare gli operai, finché non arriva di nuovo quello che finora mi ha massacrato di prese per il culo, a me e ai miei occhiali. Si avvicina. Mi alzo, quasi d'istinto, e con il randello in mano gli dico:
- Se tocchi la gatta ti spacco il capo, pezzo di merda.
Così, senza motivo. O meglio, sì. Avevo paura che volesse farle del male, a lei e ai gattini appena nati. “Ma io...ma io...volevo dirti solo che s'è finito il lavoro...”. Dovevo averci, forse, una brutt'aria, oppure era la mia presa di coscienza di appartenere alla classe felina. Non è che si diventa Pampalea a caso; però le coscienze e le classi non sono cose semplici. E chi si diverte a far troppe semplificazioni, appartiene solo alla classe dei babbei.
E, infatti, lo avevano finito, il lavoro. L'altro, con l'apparecchio, stava controllando la linea (che non c'era ancora); forse, chissà, la sera o il giorno dopo. E se poi la linea veniva anche un mese più tardi, sai che importanza; arrivò, comunque, nemmeno tre ore dopo.
Non mi disse più nemmeno una parola, mentre rimballava le sue cose e l'altro operaio, quello che era stato sempre zitto, sogghignava. La gatta, nel frattempo, si era presa i gattini uno per uno, agguantandoli con la bocca per la pelle del collo, e li aveva portati chissà dove nel campo, al sicuro; ché poi, in campagna, di sicuro non c'è mai niente. Chissà quanti ne sarebbero sopravvissuti; ma così va, e da sempre, e lo sapevo anche se avevo gli occhiali e studiavo la filologia germanica. Forse gli avevo messo paura, chissà; forse aveva pensato davvero che gli avrei tirato una randellata; ma avevano lavorato duro, e il loro pane se l'erano guadagnato, i loro pochi soldi d'una mattinata al servizio, come tutti, del sor padrone che finiva in -tel.
Tre ore dopo, l'avvenimento. Alzo la cornetta e sento il tu-tu-tu. E non resisto: compongo un numero, che però non è quello di casa. Chiamo un'altra persona, per raccontarle dei gattini appena nati: è la prima telefonata fatta nel ventesimo secolo dal Formicaio, frazione rurale di Marina di Campo, Isola d'Elba, provincia di Livorno, Italia. Il cavo pende dai rami del suo susino; lo farà, e senza alcun problema, per quasi vent'anni. Fino a una sera settembrina di tempesta quando un fulmine lo colpirà incenerendolo e scaricandosi addosso ad un tizio che, per l'appunto, stava al computer a scrivere un post su un newsgroup dopo aver passato una meravigliosa giornata ad essere processato a Livorno; non vi dico chi è. Era un lavoro ben fatto, con quei cavi tra i pali, le susine e il cielo; hanno fatto in tempo a far marciare anche Internet.
Ho letto, in questi giorni, un po' di cose dove si parla di operai. Volevo dire la mia, ma la mia è quasi sempre disassata, sbalestrata. Sarò fatto così, ma poi ognuno ne tragga le conclusioni che desidera perché detesto sempre di più le operette morali e mi piacciono, invece, le libertà d'intendere che promanano da ciò che si sceglie di raccontare. Pure oggi ho mandato pesantemente in culo un operaio che non voleva farmi passare col furgone; gli faceva fatica spostare una transenna di quindici centimetri. Ho sempre gli occhiali, ma non mi si prende più tanto facilmente per il culo a gratis. Sono sceso dal furgone e la transenna gliela ho spostata io, ma con una pedata. Stava rifacendo un muro, lavorando senz'altro benissimo, e per i soliti pochi soldi di un padrone di merda.
lunedì 8 febbraio 2010
Ah, Ça ira, maremma cignala!

Ciononostante, stavolta in un afflato di ben più venturiana incoerenza, a me i cacciatori e la caccia proprio non mi riesce di farmeli stare simpatici; anzi, direi che in linea di massima mi stanno, sia in veste di singoli che in quella, ben più perniciosa, di lobby, notevolmente sul culo. E questo ben prima dell'attuale leggina berluscazziana, contro la quale persino qualche cacciatore un po' più dotato di gnègnero si è opposto. Gli anticaccia, quelli veri, duri & puri, avrebbero anche la mia ammirazione se non fosse che, davanti a un piatto di tagliatelle a i' sugo di cignale, o a un vasetto di sarcicce sott'olio, vengo colto da subitaneo deliquio e mi ci butto sopra come Klaus Dibiasi dalla piattaforma di 10 metri. Saranno, come si suol dire, umane debolezze, per le quali non accampo scuse; e, ovviamente, continuerò imperterrito sia a addentare manicaretti a base di cacciagione (cosa che mi capita, invero, al massimo due volte all'anno se va bene), sia a farmi stare sul culo i cacciatori e la loro attività (che almeno vorrei non fosse definita sport).
Ma, oggi, sono anema e core dalla parte dei cignali. Me li immagino nelle boscaglie maremmane di Bolgheri seduti in cerchio, con tutti i loro cignalini, a spanciarsi dalle risate. È successa, proprio da quelle parti, una cosa. Una di quelle cose che, caccia o anticaccia, cignale o tofu al seitan, mi ha fatto sobbalzare sulla sedia ritirando fuori tutto il mio mai sopito giacobinismo. Una festa di nobilastri, di aristocazzi di merda generalmente riciclatisi come imprenditori di successo, con la relativa e immancabile battuta di caccia. Al cignale, giustappunto. Trasformatasi all'improvviso in una qualsiasi battuta di proletari, di quelle dove -mi son sempre chiesto come mai- si fanno sempre fuori tra cognati. Lo si legge a metà agosto sui giornali, a ogni apertura della caccia: "Tragedia ne' boschi di Suvereto - Uccide il cognato durante la caccia", oppure, "Spara al cognato e lo ammazza, credeva fosse una quaglia" (sospetto che, almeno a volte, più che di quaglie si debba parlare di cervi e che dietro tutte 'ste ammazzatine venatorie ci siano inconfessabili regolamenti di conti in famiglia per questioni di corna).
Stavolta, invece, niente cognati. E niente proletari. C'è tutto il Gotha della zona, in quel "luogo magico e amatissimo dall’aristocrazia di tutta Europa" (così vola pindaricamente il "Corriere della Sera"). Stavolta l'impallinamento letale è toccato nientemeno che al conte Giuseppe Orlando, sposo di una Della Gherardesca e, quindi, discendente del Conte Ugolino. Sì, perché questi qui si sposano tuttora sempre fra di loro, si fanno le feste fra di loro, ci hanno le tenute più belle in Maremma, si accignalano reciprocamente le loro spose e, talora, durante il rito millenario capita loro di ammazzarsi a vicenda come dei bischeri qualunque. Come il Pinzauti Piero che fa fuori il cognato Lascialfari Giuseppe. Come il Degl'Innocenti Ettore che stende l'amico fraterno Bartoli Ottavio, con il quale andava a caccia fin da ragazzo.
Ora, magari, i cignali forse si aspetterebbero che queste cose toccassero giustappunto ai Pinzauti, ai Lascialfari e ai Bartoli, a questi vili pezzenti che possono anche accopparsi al massimo con un trafiletto di dieci righine in cronaca locale. Sì, perché di incidenti in questo "sport" che addirittura taluni vorrebbero chiamare arte ne succedono parecchi. Succede sempre dove, per un motivo o per l'altro, c'è gente che imbraccia delle armi. Invece no. I cignali debbono oggi ricredersi con gran sollazzo: nonostante tutta l'attrezzatura, nonostante le postazioni nascoste e i palchetti rialzati, ieri uno dei venti sceltissimi cacciatori di quelle nobìllime famigliuole d'antichissimo lignaggio ha spedito a babboriveggi il conte Orlando con un proiettile calibro 30 sparato da una carabina. Proiettile senz'altro destinato a un cignale che, oggi, ringrazia la su' madonna cignalessa non senza essersi debitamente pisciato addosso dal ridere.
O che ci volete fare. Io ero uno di quelli che, persino alle scuole medie, quando si faceva la Rivoluzione Francese tifavo quasi da stadio quando il professore spiegava degli incendi appiccati dai contadini alle avite tenute di quei parassiti merdosi, delle teste che rotolavano nei panieri, del cittadino Luigi Capeto portato al patibolo la livida mattina del 21 gennaio 1793 e di quella schifosa dell'Austriaca alleggerita anch'essa della testolina. Non mi hanno mai fatto brillare gli occhi né le vicende della Primula Rossa, né quelle dei Vandeani. Magari, all'epoca, è ragionevolmente certo che prima o poi anch'io sarei stato passato per l'invenzione del citoyen De Guillotin, ma pazienza; dé, vo' mètte. Abbasso tutti questi luridi, in ogni epoca e in ogni paese; e mi sia scusato se, nell'attuale paese dell'amore mi ostino a fare queste decise dichiarazioni di odio di classe.
Questi mica sono come me e come te, lettrice o lettore, anticaccia o cacciatore che tu sia. Questi trasformano ogni cosa in separazione, in recinzione. Le loro meravigliose tenute dove fanno i loro preziosissimi vinelli, come ad esempio il Sassicaia di quelle contrade lì: per farne una Molotov bisognerebbe averci fior di bigliettoni per acquistarne una bottiglia millesimata (e, peraltro, le molotov vengono meglio con le bottigliacce da spumante da du' soldi, quelle col fondo rialzato e di vetro spesso). Le loro élites. Il loro lusso orrendo mentre qui si crepa. Le loro spose, i loro figli e i loro avi che mica si possono chiamare come noi comuni mortali: il defunto Orlando era figlio di Sibilla e i suoi figli si chiamano Cloe e Tancredi. T'an credevi, eh, di finì sparato come un cognato qualsiasi di Montaione o di Vicchio del Mugello. T'an credevi che la tua "dinastia leader imprenditoriale nel campo del rame" (chissà se si serviva anche delle miniere cilene riprivatizzate da Pinochet...) tu non te la potessi più godere, proprio ora che il prezzo del rame, l' "oro rosso", è schizzato alle stelle, e che non so quanti poveracci e diseredati lo vanno persino a rubare dalle linee elettriche ad alta tensione o dalle traversine ferroviarie, rimettendoci sovente la buccia in un modo un po' meno nobiliare ed anche ben più atroce.
E allora, unendomi per una volta ai cignali che se la spassano, li invito a cantare assieme a me il Ça Ira!, che ce n'è uno in meno. Via questa merda puzzolente dalla faccia della terra. Via aristocratici, conti, baroni, grassi borghesi, imprenditori leader; e che la Maremma, e le sue terre, e le sue antiche case, i suoi boschi ed anche i suoi animali siano restituiti a chi lavora. Saremmo nati o no per marciare sulla testa dei re? Beh, intanto potremmo anche farlo su un nobile imprenditore sbudellato per la sua stronzata di rito millenario. Se ne fosse rimasto a passare la domenica a trombarsi la sua bella sposa, invece d'alzarsi all'alba per andare a giocherellare con le carabine, non gli sarebbe successo.