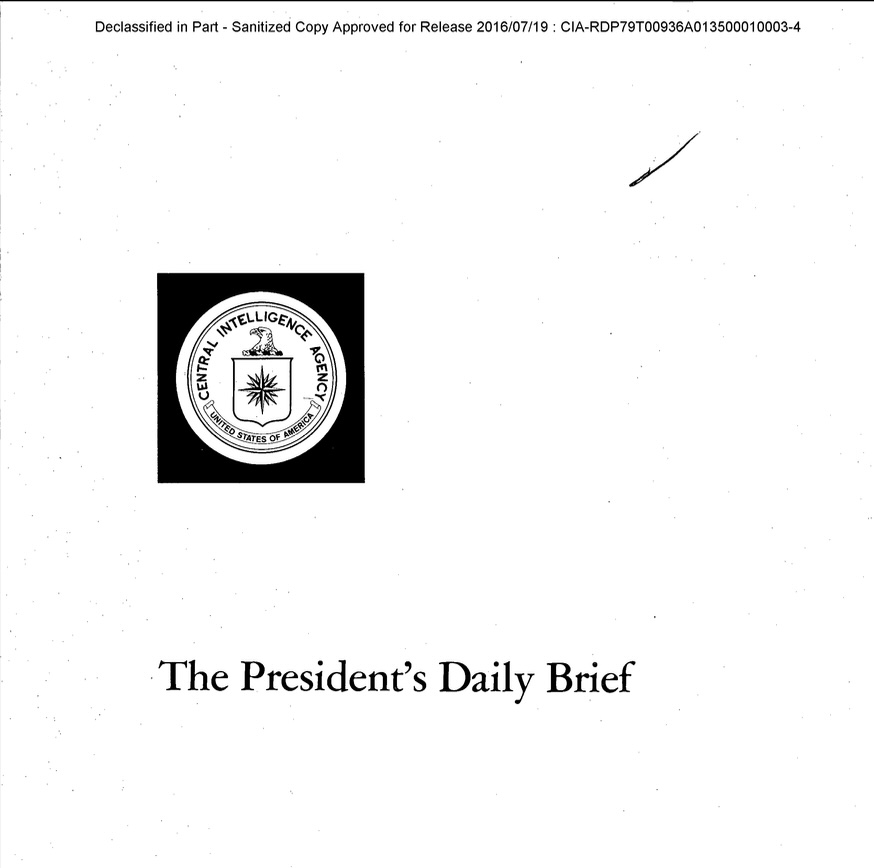Poi, questa canzone. E' sempre difficile trattare per il verso giusto una canzone che parla di qualcuno che, al tempo stesso, si dice di sentir vicino, e del quale in realtà non si sa un bel nulla. Né di lui, né di quel che ha davvero fatto nella sua vita. Da quando Vittorio Arrigoni è stato ammazzato a Gaza, per quel che mi riguarda ho sempre cercato di ribadire quest'ultima cosa rifiutando categoricamente di chiamarlo con quel nomignolo di “Vik” che presupporrebbe, almeno per me, di averci giocato a tappini da bambino a Besana in Brianza o di avere sfidato bombe a grappolo e blocchi militari israeliani a Gaza. Troppa finta familiarità, che casomai avevano con lui quelli che a Gaza ci sono imprigionati a cielo aperto, e forse non è aperto nemmeno quello. Queste sono premesse per me necessarie, parlando di una canzone come questa. L'ha scritta Marco Rovelli, di recente, e ancora non l'ha pubblicata in nessun album; e chissà se quest'album ci sarà mai; una cosa che mi piace, è d'averla ascoltata per la prima volta in un parco d'una periferia urbana, intitolato a Iqbal Masih, che corre il rischio di scomparire perché il borgomastro ci vuol fare una strada. Non saprei dire perché, ma è una cosa che, a modo suo, sa di Gaza. Sa di violazioni e resistenze. Sa di prepotenze e di risposte. Sa di disumanità e umanità. Coi conigli che saltellano in mezzo a future macerie, con le galline che fanno le uova in mezzo alle macerie presenti.
Detesto le agiografie, anche perché hanno il vizio di essere messe in atto dopo la morte di qualcuno. Vittorio Arrigoni non doveva essere né una vignetta né fotografie con la pipa; doveva essere i suoi occhi, le sue gambe, i suoi bicipiti. Doveva continuare ad essere la sua Utopia viva, non un'Utopia morta. Non doveva essere un argomento di canzoni, e chissà perché le canzoni si scrivono sempre post mortem; ma che ce ne sia una mentre un Arrigoni è ancora vivo e vegeto, e destinato ad essere eliminato dagli israeliani. Marco Rovelli, se lo conosco un po', se ne dev'essere accorto e deve avere sentito questa stortura; così come deve aver pure lui ragionato sul fatto di non creare il “santino-Arrigoni”. Se tanto mi dà tanto, Vittorio Arrigoni doveva essere tutt'altro che un santo, e non mi convincono troppo le etichette di “pacifista” che gli sono state affibbiate da alcuni. Non ce lo vedo di certo ad invitare i gazioti a “deporre le armi” o a “disertare”; Vittorio Arrigoni era un combattente, che le armi le impugnasse o meno. Un combattente sul campo. Ed è qui il discrimine, che investe qualsiasi cosa: noialtri, quelli che scriviamo articoli e canzoni, che disquisiamo di Utopie un giorno sì e un giorno sì, che magari ci scanniamo pure sui siti, sui blog e su “Facebook” per un' “interpretazione della figura” (figura morta, of course), non combattiamo proprio una sega e a Gaza o in chissà quale altro posto dove si muore sul serio, d'assedio, di oppressione, di imperialismo, di narcotraffico e di tutte le altre merde dell'Universo, non solo non c'eravamo, ma non ci metteremo mai piede. Certo, parliamone poi, ma sempre con il pudore di rifuggire dalle icone e mettendo bene in chiaro la nuda realtà dei fatti. Senza indulgere all'autoflagellazione, ma neppure trasformandoci arbitrariamente in tanti Arrigoncini che non siamo e che non diventeremo certo con delle parole (sempre naturalmente che lo vogliamo diventare). Peraltro, credo che sia un modo per “restare umani” (sempre naturalmente che lo vogliamo restare).
E così, in questa “Canzone per Vittorio Arrigoni”, Marco Rovelli ha in realtà parlato di Gaza. Ché di Arrigoni, in fondo, ce n'è abbastanza poco; e non credo che la cosa gli sarebbe dispiaciuta. C'è molto, invece, di quel che Arrigoni vedeva e combatteva ogni giorno. C'è Gaza e la sua vita, e la sua morte. C'è la definizione dell'Utopia, che consiste nel percorrere, nel navigare e in una serie di azioni quotidiane che sverniciano gli strati di orrore accumulati sopra quel miscuglio dato da un tempo, da un luogo e da una galera. E ne sia dato atto, al Rovelli che va nei parchi da smantellare, a cantarlo.
Ma dicevo, all'inizio, di una lista di cose per le quali Vittorio Arrigoni faceva paura, e continua a farla. Faceva paura per la sua determinazione nei confronti di poteri che chiunque di noi non saprebbe nemmeno come cominciare ad affrontare. Faceva paura perché non si fermava. Faceva paura perché non si masturbava con vuote filosofie, con bizantinismi e sofismi, con “rivoluzioni tradite” e altre stronzate tanto care a parecchi “disillusi” di casa nostra e d'altre case. Faceva paura perché sfuggiva. Faceva paura perché agiva nel presente, nel presente viveva e nel presente è morto, rimanendoci abbarbicato fino all'ultimo. Faceva paura perché non aveva “mitici passati”, né vissuti e né immaginati; faceva paura perché non giudicava sulla base di astrazioni imbecilli, come invece hanno fatto alcuni che gli hanno dato addosso anche dopo morto perché, magari, sul suo sito/blog aveva un link a qualcuno che restava loro antipatico (“aveva un link a degli stalinisti!”, sentita anche questa, e basta a vomitargli veleno addosso oltre a quello dei “Liberi & Giornali”); faceva paura perché faceva rabbia; faceva paura perché non temeva di farsi nemici; faceva paura perché tra i suoi nemici di prima e di poi ci sono anche i falsi del “sì, però...”, ci sono non so quanti “compagni” perché lui era compagno soltanto di chi crepa ogni giorno, e talmente tanto da creparci anche lui ripetute volte, e non soltanto per i “Salafiti” o chissà chi cazzo erano e chi li mandava. Faceva paura perché ci aveva quel paio di bicipiti che gli servivano per fare, agitare, scombinare, e tutta un'altra serie di cose per le quali dei bei muscoli servono più del piagnisteo sui propri “vent'anni”, sulla “generazione” e su chissà qual altra idiozia. Faceva paura, credo, soprattutto per una cosa. Perché mostrava come l'Utopia non sia affatto fatta di costruzioni teoriche, sia pur belle o addirittura grandiose; proponeva un'Utopia fatta, invece, di pezzi di pane, di reti da pesca, di taniche di benzina, di apparecchi per la dialisi. Un'Utopia dove quei pezzi di pane, quelle reti, quelle taniche, quella benzina e quegli apparecchi non erano, peraltro, nessuna forma di “umanitarismo”, bensì di lotta per una vita finalmente normale. Un'Utopia dove chi vive in un luogo massacrato dalla Realtà avesse persino il proprio diritto alla Mediocrità, al quotidiano, alla piccolezza. Alla vita, cioè. Ed è l'Utopia che fa più paura proprio ai biascicatori di “utopie” che resteranno tali.
Mi sa, in fondo, che Marco Rovelli abbia anche parlato di questo nella sua canzone; ad esempio, descrivendo tutta una serie di persone normali che vivono nella normalità di una situazione pazzesca come quella di Gaza. O forse mi piace solo pensarla così. Chissà. Ma i bicipiti di Vittorio Arrigoni continuano a parlare di quell'Utopia di tutti i giorni che, chissà, un giorno anche noi potremmo vivere. Basta poco per trasformare in Gaza anche la nostra linda cittadina, il nostro bel quartiere pieno di verde, il nostro bel lungomare alberato, il nostro mondo nel quale ci ribelliamo nella distanza che corre dalla sedia all'uscio che dà su una pace che non c'è, che non c'è mai stata. Il nostro mondo nel quale “restare umani” farebbe parte, sì, di quell'Utopia quotidiana di cui sopra; ma, in realtà, restiamo soltanto sospesi. E anche di questo non tanto la canzone, quanto Vittorio Arrigoni stesso, parlava; per questo, in realtà, ne avevamo una paura fottuta quand'era vivo, e ne abbiamo ancora di più ora che è morto.
Ci vuole il mare e tanta fantasia
E tu che avevi il nome di Utopia
Vedevi il cielo dentro la tua stanza
Il cielo aperto che cade nel mare
E il mare lo sa di non avere confini
I confini son roba di piccola gente
Che vive per poco e muore per niente
Per vedere ciò che non si vede
Bisogna avere fede e coraggio
La fede che qualcosa deve accadere
E il coraggio che chiede di volerlo vedere
E la tua Utopia ha preso il largo a vent’anni
Hai scelto l’aperto del mare, o del cielo
Che poi è lo stesso concetto:
Che qui c’è un mondo da fare
E la tua Utopia è arrivata in barca a Gaza
E lì ha preso casa
In quella striscia di terra senz’aria
C’è bisogno di respirare
Mani ferme sul timone
Con il sole sulla faccia
Barra dritta, Utopia
Navigare, navigare
Con le ali di gabbiano
Né bandiere né frontiere
Il mare è di chi resta umano
Le bombe cadevano, bruciavano i corpi
Fiorivano gl’incubi al gelo del cielo
Il piombo fuso colava, la gente crepava
E non c’era misura per questo scempio,
Per questo massacro portato ad esempio
Al mondo intero, e allora scrivevi per farne figura,
per toglier paura a chi non s'è arreso
Dicevi dei segni lasciati nei sogni dei bimbi,
i visi scalfiti da rughe dei vecchi
che han visto due naqba e aspettan la morte
così come han vissuto, e han vissuto in gabbia,
e tu in quella gabbia sei voluto tornare,
in nave, per mare,
in migliaia erano al porto ad aspettare
le prime navi dal ‘67
E il tuo mare racconta, c’è da raccontare,
che cosa si vuole dopo quel terrore
Che non è difficile immaginare
che si vuole una vita normale.
Mani ferme sul timone
Con il sole sulla faccia
Barra dritta, Utopia
Navigare, navigare
Con le ali di gabbiano
Né bandiere né frontiere
Il mare è di chi resta umano
Il silenzio dei bambini
che ti guardavano giocare
quel piccolo abbandono
che vi ha fatto abbracciare
Sulle strade troppo strette
di un quartiere senza nome
Un gioco che ti consegnava
alla tua rivoluzione
Che poi sarebbe meglio dire
che è la tua rivolta
ma il mondo non ascolta
e tu ti lasci trasportare
Dalle onde così alte
che ti sembrano colline
sono storie, rose, spine,
che non smetti di ascoltare
Hamza, il miscredente
che un giorno si è convertito
ed è morto, l’arma in pugno
ma dov’è il suo paradiso?
E Maha che in una terra
sempre più verde di martirio
si toglie il velo dalla testa,
basta con il sacrificio
E Fida che al contrario
il velo lei non lo portava
e decide di volerlo,
non vuole essere schiava
E poi tutti i tuoi amici
contadini, pescatori,
minatori dentro al tunnel,
di una terra senza un fuori
E chi distilla l’alcool,
e chi canta la sua canzone
e chi sogna un’altra terra,
e le coppie che fanno l’amore
E la vita che ci prova,
ci prova ad essere normale
e c’è sempre tutto un mondo
che si deve liberare
Mani ferme sul timone
Con il sole sulla faccia
Barra dritta, Utopia
Navigare, navigare
Con le ali di gabbiano
Né bandiere né frontiere
Il mare è di chi resta umano